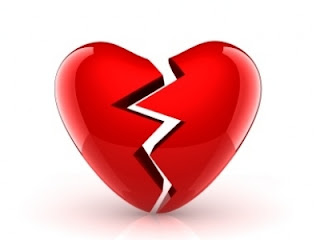Huker
sentiva la testa martellargli, come sempre, dopo un litigio con Sunda. Si
chiedeva spesso se sua moglie avesse fatto un corso specifico per imparare a
dargli sui nervi o se fosse un talento naturale. Era un dubbio che probabilmente
non avrebbe mai risolto. Attivò lo spazio-sensore della navicella. La
propaggine traslante anteriore entrò dalla finestra del suo appartamento al
trentacinquesimo piano. Soffriva l’altezza, ed era costretto a scegliere sempre
piani sotto l’ottantesimo, questo lo obbligava a soffrire tutte le pene della
salita dell’uovovettore quando doveva prendere l’aero-robot dall’hyperbox sul
tetto del grattacielo.
Huker
sentiva la testa martellargli, come sempre, dopo un litigio con Sunda. Si
chiedeva spesso se sua moglie avesse fatto un corso specifico per imparare a
dargli sui nervi o se fosse un talento naturale. Era un dubbio che probabilmente
non avrebbe mai risolto. Attivò lo spazio-sensore della navicella. La
propaggine traslante anteriore entrò dalla finestra del suo appartamento al
trentacinquesimo piano. Soffriva l’altezza, ed era costretto a scegliere sempre
piani sotto l’ottantesimo, questo lo obbligava a soffrire tutte le pene della
salita dell’uovovettore quando doveva prendere l’aero-robot dall’hyperbox sul
tetto del grattacielo.
Almeno
l’uovovettore era dotato di dispositivi di stazionamento e riequilibratura che
impedivano di sentire il dislivello della salita. I visori tridimensionali
erano studiati per persone che soffrivano di vertigini come lui e davano la
sensazione di planare lentamente a pochi centimetri dal suolo.
La
propaggine traslante s’infilò nella navicella metallica ancorata a un migliaio
di metri dal suolo scodellando Huker con dolcezza sul sedile dell’aero-robot
Ygar 3600.
Al contatto
del corpo di Huker con il sedile, il casco trasmettitore scivolò sulla sua
testa e il sedile si incurvò lentamente prendendo la forma che, secondo il
dipartimento di medicina interplanetario, era il più opportuno in
considerazione della struttura ossea di Huker, dei carichi che stava portando,
e del tipo di alimenti che aveva ingerito nelle ore precedenti.
Sullo
schermo della consolle, apparve il messaggio di benvenuto, che partiva assieme
alla musica di apertura, un motivo popolare in quel momento che Sunda aveva
scelto.
Sunda era
più portata di lui per la tecnologia, e aveva predisposto lei i settaggi
dell’Ygar 3600. Huker si era limitato a richiedere un paio di
personalizzazioni, per le quali Sunda aveva commentato, con aria di
sufficienza:
- Tutto qui?
Dopo il
messaggio di benvenuto era partita la schermata di check up di Ygar 3600. In un
tempo quasi impercettibile il veicolo veniva esaminato minuziosamente. In caso
fosse stata necessaria la manutenzione, l’auto-robot si sarebbe messo in
contatto direttamente con la casa produttrice che avrebbe scelto l’officina
utile più vicina.
-
Maledizione!
Huker era un
uomo d’indole pacifica, la mattinata però era stata carica di eventi spiacevoli
e quello che apparve sullo schermo era solo la ciliegina sulla torta.
“Manutenzione
straordinaria – recarsi su Elios VI per intervento urgente – priorità massima”.
Questo
voleva dire diverse cose, una tra tutte: l’intervento sarebbe stato a carico
dell’azienda produttrice. Il pensiero non diede a Huker alcun sollievo. Nulla
avrebbe impedito il litigio che sarebbe scoppiato tra lui e Sunda. Gli sembrava
di sentirla:
- Dovevi venire
a prendermi alle otto. Mai che tu faccia una cosa in tempo... Non si può mai
fare affidamento su di te!
Al pensiero
Huker spinse il pulsante di partenza. Forse non sarebbe dovuto partire, forse
sarebbe dovuto rimanere lì a decidere il da farsi, o forse avrebbe dovuto chiamare
Sunda dall’infocom per spiegarle la situazione. Ma non ne ebbe il tempo.
L’auto-robot
era partito con un guizzo metallico e in pochi secondi aveva percorso centinaia
di chilometri spaziali, una distanza enorme. Sapeva già dove dirigersi.
Il sistema
di automanutenzione, con i mezzi più moderni, era stato completato da un
sistema di navigazione intergalattico sofisticatissimo. I due sistemi
interagivano e non appena l’elaboratore principale trasmetteva il segnale di
manutenzione, dal navigatore intergalattico partiva la ricerca dell’officina
più vicina. Una volta individuata l’officina, il sistema la definiva come destinazione,
calcolava il tempo di navigazione, il fabbisogno di energia e le eventuali
soste di recupero, il tutto senza che la persona a bordo dovesse fare nulla. O
anche, semplicemente, potesse fare nulla.
Huker si
rilassò. Era talmente arrabbiato con Sunda, quando era uscito di casa, che non
aveva preso con sé nulla per passare il tempo. Normalmente gli piaceva, durante
il percorso, fare delle copie di se stesso con il neurosimulatore. Aveva
inventato centinaia di possibilità, come sarebbe stato se avesse avuto genitori
diversi, se avesse fatto studi diversi, se non avesse sposato Sunda. Era solo
un gioco, però, ecco, faceva riflettere. Il neurosimulatore, però, era rimasto
a casa, in bagno, accanto alla vasca a ultraluci.
Per
distrarsi un po’, chiese al sistema di proiettare il manuale d’uso del
Navigatore Interstellare Siderius 5.0. La proiezione partì con un sibilo:
“Il
sistema di navigazione interstellare Siderius 5.0 è il più avanzato sistema di
navigazione inventato per orientarsi nello spazio intergalattico. Siderius 5.0
è dotato delle mappe delle maggiori galassie conosciute, ed è in grado di
orientarsi sfruttando lo spettro della luce proveniente da ogni corpo celeste.
Siderius 5.0, inoltre, è in grado di calcolare il tempo di rotazione di ciascun
corpo celeste, la gravitazione reciproca dei corpi, nonché la probabilità di
eventi quali comete, meteore, meteoriti...”
Huker si
addormentò. Il manuale tecnico continuò la propria spiegazione, mentre Ygar
3600 stabiliva la propria rotta in base alle informazioni che Siderius 5.0
calcolava incessantemente.
- Che vuol
dire?
- Quello che
ho detto Reus. Esattamente quello che ho detto.
Reus Fiutre
si alzò dalla scrivania fluttuante e si fece scivolare sulla rampa d’appoggio
in metallo. Amava il design ardito, amava tutto ciò che era audace.
- E’
scappata?
- Direi di
sì. In realtà credo che, a rigore, sia semplicemente andata via. Credo fosse
suo diritto. – l’ingegnere capo disse l’ultima frase con voce sommessa. Sapeva
quanto Reus fosse restio a negare qualunque diritto al di fuori dal proprio.
- Suo
diritto un corno! Lei può andare dove diavolo vuole, ma i progetti? I manuali?
I disegni? Sono della Ygar, non può farci quello che vuole, no?
 Desker,
l’ingegnere capo guardò a lungo il pavimento della stanza sotto i propri piedi,
fino ad apprezzare ogni piccola scheggia di cristallo luminescente. Alla fine,
alzò la testa per dire, con malcelata mestizia:- Non proprio,
Reus...
Desker,
l’ingegnere capo guardò a lungo il pavimento della stanza sotto i propri piedi,
fino ad apprezzare ogni piccola scheggia di cristallo luminescente. Alla fine,
alzò la testa per dire, con malcelata mestizia:- Non proprio,
Reus...
- Che
diamine vuol dire: “non proprio, Reus”? – esplose Reus, tentando di
scimmiottare, nell’ultima parte della frase, il tono dolente di Desker.
- Vuol dire
che... Quando ha depositato i progetti, l’ha fatto a proprio nome, non a nome
dell’Ygar Inc. Sono suoi, e può farne quel che vuole, questo vuol dire.
- Legalmente
non possiamo fare nulla?
- Direi
proprio di no.
Reus era
furioso. Quella piccola... L’aveva detto e l’aveva fatto. Anzi, “quasi” fatto.
Kelen era di
una bellezza ammaliante e di una sensualità impareggiabile. Era anche
orgogliosa e gelosa. Aveva accettato di rimanere a lavorare alla Ygar dopo
l’inizio della loro relazione, ma aveva posto alcune precise condizioni. Non
voleva promozioni o favoritismi, desiderava solo poter continuare a lavorare
sul progetto Siderius 5.0 da sola e prendere una percentuale su quello che la
società avrebbe guadagnato dalle vendite del prodotto.
A Reus era
parso un affare d’oro. Kelen Geis era l’ingegnere più brillante della sua
società e gli sembrava che le condizioni da lei poste fossero ragionevolissime,
persino un po’ futili. Aveva attribuito la richiesta all’orgoglio di Kelen,
alla sua ingenuità, unite al fatto di aver perso la testa per lui.
“Forse”
pensò “non era poi così ingenua”.
Doveva
ammettere che aver depositato i progetti a proprio nome era stata una bella
mossa e, nel medio termine, avrebbe potuto causare qualche problema.
Una delle
ragioni del successo dell’Ygar 3600 era stata l’installazione di serie di
Siderius 5.0. Se Kelen avesse venduto l’idea ai concorrenti sarebbe stato un
brutto colpo. Ma Reus avrebbe saputo farla ragionare.
Il loro
ultimo colloquio si era chiuso in maniera piuttosto spiacevole. Ma si sa,
quando una storia finisce, volano parole grosse.
- Io ti
rovino! – gli aveva detto Kelen, con freddezza.
All’inizio
la cosa lo aveva un po’ spaventato, ma poi si era detto che il massimo che
poteva fare era causargli qualche piccola bega legale. I suoi avvocati erano i
migliori. L’ingegner Geis avrebbe fatto meglio a mettersi l’anima in pace: se
pensava di rovinarlo per così poco, non conosceva le risorse di Reus Fiutre.
- Va pure
Desker. Chiama i tuoi ingegneri, voglio un piano per fronteggiare l’emergenza
entro domani. Voglio una stima accurata di quanti Ygar 3600 sono stati già prodotti
col sistema Siderius e quanti sono ancora in produzione. Voglio inoltre che
chiami a rapporto il nostro gruppo tecnico, ho bisogno di sapere che cosa
conoscono del sistema e se sono in grado di copiarlo. Voglio poi un rapporto
dell’ufficio legale. Voglio sapere se possiamo rivalerci nei confronti di Kelen
e, soprattutto, come possiamo continuare ad installare il Siderius ora che lei
non è più nella società. Chiaro?
- Chiaro.
Desker uscì
dalla stanza con la testa bassa. Conosceva Kelen e l’ammirava. Quella mossa gli
sembrava al di sotto delle potenzialità del giovane ingegnere, la donna più
bella e più in gamba che avesse mai conosciuto. Sentiva campanelli d’allarme e
brividi per tutto il corpo. Dalla cintura a pulsioni digitò il codice
d’emergenza. In quell’istante ogni ingegnere dell’Ygar Inc. veniva risucchiato
nel tunnel preferenziale in direzione della sala riunioni principale.
Huker si
risvegliò di colpo. Aveva una sensazione di panico e non capiva perché. Quando
guardò il visore tutto gli fu più chiaro. Sunda lo stava cercando. Rispose alla
chiamata.
- Huker?
- Sì, Sunda.
- A che ora
pensi di passare?
- Sarò un
po’ in ritardo, ho dei problemi con l’auto-robot. Ti chiamo non appena arrivo
all’officina.
- Huker...
- Conosci le
procedure, non avrei potuto passare a prendere te, prima di passare
dall’officina neanche se avessi voluto.
- Non fare
troppo tardi. A dopo.
Huker sapeva
che non sarebbe servito. Era colpevole agli occhi di Sunda. Era passato un po’
di tempo, in effetti. Huker trovò strano non essere già arrivato a destinazione.
L’officina doveva essere lontana, il che era piuttosto insolito.
Gli bastò
una rapida occhiata al visore per capire che erano andati ben oltre l’officina,
erano andati ben oltre i confini del sistema planetario.
In quel preciso
istante, lo Ygar 3600 stava lasciando la galassia.
- Reus...
Reus Fiutre
guardò la sua assistente, Osiu, entrare nell’ufficio tramite la porta a strati
concentrici. Era un bello spettacolo, Osiu era stata un ottimo acquisto a parte
il ruolo che aveva avuto nella faccenda Kelen. Le cosce più conturbanti del
pianeta: Reus ne era ormai certo.
- Dimmi.
- Il nostro
sistema di controllo riporta qualche problema.
Osiu fece
scivolare nel visore un goccio-doc. Il tubo si riempì in un attimo e di fronte
a Reus si materializzò il rapporto del sistema centrale.
Reus ebbe
bisogno di qualche minuto per comprendere la portata di quello che stava
accadendo.
- Che vuol
dire?
Osiu era
sparita. Aveva previsto la domanda e non avrebbe saputo rispondere: per questo
aveva chiamato Desker, che aveva lasciato la riunione degli ingegneri per
correre nell’ufficio di Reus. “Kelen... Che donna!”, aveva pensato,
leggendo il rapporto.
- Desker,
che sta succedendo?
- Non lo so,
Reus. Da quello che siamo riusciti a capire, tutti gli Ygar 3600 partiti oggi
hanno ricevuto un segnale di manutenzione obbligatoria. Nessuno dei milioni di
veicoli partiti ha però mai raggiunto un’officina.
- E dove
sono finiti?
-
Sembrerebbe fuori dal sistema... e dalla galassia. Fuori da ogni controllo.
Kelen! Quindi era questo. La piccola
serpe!
- Io ti
rovino!
Reus non
rispose. I soccorsi, le assicurazioni, il risarcimento danni, l’immagine. Proprio
così: era rovinato
- Se ti
serve qualcosa...
Reus rimase
immobile.
Desker
lasciò l’ufficio. Non sarebbe stato difficile trovare lavoro per un ingegnere
della sua esperienza. Certo la reputazione della Ygar Inc. aveva ricevuto un
duro colpo, ma lui non aveva mai lavorato sul Siderius 5.0.
Osiu stava
portando via le proprie cose.
- Desker, mi
dai un passaggio?
Desker la
guardò, la bella schiena curva, le cosce ritte sui tacchi. Reus aveva gusto.
- Come no!
Andiamo.
Huker non
capiva che cosa stesse succedendo, si era avvicinato ad una zona sconosciuta e
stava orbitando attorno ad un grosso pianeta. Non riusciva ad impostare alcuna
destinazione sul Siderius né a comunicare con nessuno.
Dal visore
partì un com-messaggio.
“Gentili signori, ci spiace molto
per l’inconveniente, dovuto ad un guasto del sistema di navigazione. E’
impossibile, purtroppo, recuperare le vostre navicelle. Inserite le vostre
propaggini traslanti, vi trasporteremo su una nave di soccorso che vi riporterà
tutti a casa. Probabilmente saranno necessari più viaggi, ma pensiamo di
riuscire a completare il trasporto in tempi ragionevoli. Inserite il vostro
codice di priorità per aiutarci a stabilire l’ordine di partenza. Il trasporto
inizierà tra cinque minuti. Grazie”
Huker inserì
il codice più basso. C’erano certamente persone che avevano cose più importanti
da fare che andare a prendere Sunda. Si mise in attesa.
- Kelen... –
L’ingegnere capo della Gurdan, diretta concorrente della Ygar, guardò la donna
con un misto di ammirazione e timore.
- Sì?
- Che
facciamo degli Ygar rimasti in orbita intorno al pianeta?
-
Distruggiamoli.
Gli Ygar
distrutti furono ridotti in particelle piccolissime che ancora oggi si possono
osservare intorno al pianeta, un gigante gassoso alla periferia del sistema
planetario di una stella gialla, nota ad alcuni come Sol.
Da lontano
sembrano un immenso unico anello.